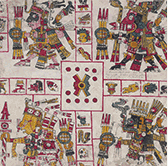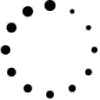Saluto del Direttore
Prolusione Scuola Biblioteconomia 2010-2011
Ottobre 2010
Mons. Cesare Pasini,
La riapertura della Biblioteca Apostolica Vaticana
Il contesto di questa inaugurazione è quello della riapertura della BAV dopo tre anni di lavori. Viene quindi l'opportunità di riferirsi a questo momento, non però per descrivere i lavori fatti, dei quali si è detto in molte sedi e sui quali non penso vi sia un interesse specifico in questa sede, ma per domandarci con quale spirito si riapre la Vaticana. Sui lavori compiuti mi permetto rimandare ad alcuni testi pubblicati in occasione della riapertura (e in parte reperibili, sul sito on line della Biblioteca, alle newsletter e alla pagina dedicata alla riapertura): La riapertura della Biblioteca Apostolica Vaticana, «Gazette du livre médiéval», 55 (2009); La Biblioteca Apostolica Vaticana riapre: un vivo desiderio di corrispondere alle aspettative, «La bibliofilia»; e in aggiunta vari interventi sull'Osservatore Romano del prefetto e poi cardinale Raffaele Farina e qualcuno anche mio. Ho ragionato su questo argomento in riferimento alla mostra che si inaugurerà il prossimo 10 novembre. Ne sono venute due possibili piste da percorrere: - la Vaticana riapre e coglie l'opportunità per farsi conoscere; - la Vaticana riapre e coglie l'opportunità per ridire la sua missione. Il testo, con il titolo identico a quello della mostra, Conoscere la Biblioteca Vaticana: una storia aperta al futuro, è in stampa nel catalogo della mostra. Alcune aggiunge sono state suggerite dal vice direttore... Mi muovo prima sull'uno poi sull'altro binario.
Ma perché inaugurare oggi l'anno accademico con questa proposta d'approccio? Ognuno di noi ha, in questo, un'esperienza diversa di accesso alle biblioteche; per molti di noi l'accesso a uno di questi luoghi è diventato o diventerà una professione, addirittura uno scopo di vita. La biblioteca non è solo un ambiente di lavoro, ma può diventare un "luogo di vita", uno spazio di riflessione, di creatività, di "senso". Spesso di questi luoghi si può avere un'impressione meramente strumentale (oltre che angusta o rinchiusa); l'esperienza di molti di noi invece è anche altro, magari con una comprensione inizialmente limitata ma che si apre a mano a mano alla scoperta di un mondo inatteso e a suo modo gradevolissimo.
1. Conoscere la Biblioteca Vaticana
Per dire della Biblioteca Vaticana che si fa conoscere e della nostra possibilità di conoscerla, chiedo venia se gioco sulla mia personale esperienza.
1.1. La fase della estraneità
Finché non frequenti una biblioteca rischi di rimanerne "estraneo". Personalmente sono rimasto "estraneo" sino al 1976, quando la necessità di consultare due manoscritti per la tesi di licenza in Scienze Ecclesiastiche Orientali presso il Pontificio Istituto Orientale mi aprì la possibilità di accedervi con una tessera abilitata a un numero ridotto di ingressi: l'invito allo studio di uno testo agiografico conservato in quei manoscritti veniva dalla professoressa Enrica Follieri, mentre la lettera di presentazione (non so se si chiamasse già di malleveria) fu stesa da padre Tomáš Špidlík, il futuro cardinale, allora professore al Pontificio Istituto Orientale. Poiché si va nella "notte dei tempi" non so ricordare che cosa pensassi della Vaticana, salvo il fatto che vi si conservasse il famoso codice B della Bibbia; studiando paleografia e utilizzando le tavole della Follieri sui codici vaticani [Codices graeci Bibliothecae vaticanae selecti temporum locorumque ordine digesti commentariis et transcriptionibus instructii, Città del Vaticano 1969 (Exempla scripturarum, 4)], presumo mi facessi qualche idea della varietà delle scritture e della ricchezza di codici in essa conservati. L'estraneo non conosce gran che di una biblioteca. Oggi – temo – l'estraneo pensa di conoscere qualcosa grazie a pubblicazioni o filmati o "you tube" vari che in buona parte non servono a nulla per conoscerla ma in compenso lasciano l'impressione, se non di conoscerla, perlomeno di poter sospettare... Lasciamo perdere.
1.2. La fase della frequentazione
Beati quindi coloro che possono entrare in una biblioteca e utilizzarla da "utenti", studiosi, ricercatori. Si tratta, almeno inizialmente – sto sempre ripercorrendo la mia esperienza –, di una conoscenza limitata all'ufficio ammissione studiosi, alle sale di consultazione, ai contatti con gli addetti nelle sale, all'acquisto di qualche volume in economato; ma intanto si possono avere le prime percezioni: di un clima di serietà, di ordine, di grande competenza, di nobile raccoglimento. Sono anche i caratteri propri della Vaticana ad essere particolarmente "accoglienti" per gli studiosi, e sono caratteri anche "biblioteconomici", che si usano subito e di cui si percepisce presto il valore: - l'abbondante e comoda disponibilità di materiali: accesso ai manoscritti in stretto rapporto con una grande sala di consultazione di stampati; - seria e serena disponibilità del personale; - lo splendore stesso dei locali che "immerge" negli studi; - la tranquillità di avere un luogo così centrale, ma allo stesso così riparato. Ho accennato prima alla professoressa Follieri: posso richiamarla qui, come studiosa che conosceva bene la Vaticana, che in Vaticana aveva trovato i suoi maestri, in Vaticana aveva compiuto molte delle sue ricerche e allo studio in Vaticana introduceva i suoi alunni. mi capita di ricordare spesso un aspetto solo apparentemente marginale: quando tocco un manoscritto, mi pare di farlo con rispetto e delicatezza (e mi meraviglio quando qualcuno agisce con preoccupante disinvoltura); sono convinto che l'atteggiamento venga da specifiche indicazioni ricevute nelle prime ore di paleografia di Enrica Follieri divenuti instradamento preciso venendo in Biblioteca. Certo, si può aggiungere, sempre facendo leva sull'accenno, nel mio caso, a Enrica Follieri, che è (o perlomeno era) usuale che un giovane studioso arrivi in Vaticana non da solo: non semplicemente per via della lettera di presentazione ma proprio perché avviato e introdotto, inserito e instradato in un ambiente, in uno stile di ricerca.
Tutto quello che ho provato a descrivere penso sia la conoscenza che abitualmente possono concedersi gli studiosi ammessi in Biblioteca Apostolica. Ovviamente, se si procede negli anni nella frequentazione, i contatti con le persone – il personale interno o i colleghi di studio – si fanno più vivi, come si fa più ampia la conoscenza dei materiali di studio a propria disposizione, dei servizi offerti in Biblioteca; forse si prende anche un poco più di confidenza con l'ambiente, tuttavia senza mai perdere il "rispetto" per un contesto così alto e degno. Si notano anche i cambiamenti o le innovazioni, ma ci si accorge che sono ben ponderati entro la scia di una "tradizione", che impronta tutta l'Istituzione e che non sembra possibile avventatamente alterare o abbandonare. Penso che una simile frequentazione, e la conseguente conoscenza, sia invidiata da chi non può entrare in Biblioteca, non avendo motivo di accedervi per ricerche di studio. Purtroppo una biblioteca specializzata come la Vaticana non può essere aperta a tutti, pena l'impossibilità di renderla disponibile a quanti da tutto il mondo vengono a consultarla per le ricerche specifiche sui materiali in essa custoditi. E del resto proprio questi materiali per la loro delicatezza e peculiarità esigono un'appropriata preparazione da parte di chi li riceve in consultazione e non possono essere concessi indifferentemente a qualsiasi "utente": mancherebbe persino la capacità di saperli opportunamente utilizzare e, per altro verso, rischierebbero di essere usati in modo inadeguato e quindi di non essere debitamente protetti e conservati per il bene dell'umanità di oggi e di domani.
Il non accesso, però, può far nascere curiosità e sospetti: si crea un alone di mistero. Può essere il mistero che fa nascere i mostri, ma qui voglio prenderlo anzitutto e soprattutto in senso positivo, perché, a dire il vero, è bello che vi sia del "mistero" là dove stanno i tesori dell'umanità, le testimonianze di una storia e di una cultura che attraversano i secoli e i continenti: in questo senso "mistero" significa qualcosa di più grande e profondo, che i non addetti ai lavori un po' sognano e un po' temono (e che nessuno può comunque accostare con superficialità!). È il mistero delle cose da scoprire, delle molte realtà che non si conoscono ancora (e forse non si conosceranno mai...), il fascino dell'attività di quanti si dedicano alla ricerca e talvolta giungono a scoprire un testo, una notizia, una bella immagine, un disegno o una fotografia, una riflessione, un dato sfuggito ai precedenti ricercatori che – magari – sono transitati tante altre volte su quelle pagine di manoscritti o di stampati, su quelle stampe e disegni, su quelle monete e medaglie, non cogliendo il punto nuovo e importante... Il mistero, quello vero, è dunque qualcosa di più grande e vasto, è inatteso, imprevedibile. Si passano giorni e giorni in ricerca apparentemente improduttiva, che poi si distende e si riordina dentro uno sguardo diverso e suscita un punto di vista nuovo. Per far spazio al mistero occorre cercare il silenzio e insieme il dialogo sereno: gli spazi della Vaticana, tra il silenzio delle sale e i dialoghi misurati nel cortile sono davvero adatti e lo sono da molti secoli.
Certo – e qui passiamo invece ai "mostri" –, se nasce il sospetto di chissà quali segreti tenuti volutamente nascosti, allora tutto si complica e si rovina: non si è più affascinati dal grande mistero (che, per dirla tutta, si appaga solo quando dalle varie sfaccettature di interessanti verità parziali si arrivi alla infinita Verità che tutto sostiene), ma si è vittime di paura e di sfiducia, di diffidenze e di pregiudizi. Da simili situazioni o stati d'animo o puntigli – dai quali possono nascere le citate pagine e filmati che affollano la rete web, con le allusioni o i sospetti più strani – è difficile essere liberati senza la collaborazione degli stessi interessati. Si potrebbe dire loro: "Venite e vedete", se almeno ne volessero trarre vantaggio!
Tanto per stare in tema di riapertura, queste tematiche sono volentieri oggetto di domanda da parte dei vari giornalisti, che magari non scrivono poi le riflessioni ascoltate, ma si mostrano se non altro sorpresi o soddisfatti di scoprire il giusto senso di mistero e il bello della ricerca della verità (minuscola e poi maiuscola).
Ma fermiamoci qui, per riprendere al volo il "Vieni e vedi", perché anche il frequentatore di biblioteca è pur limitato nel suo "vedere".
1.3. La fase del "Vieni e vedi"
Tre anni fa (21 giugno 2007) mi è capitato di sentirmi dire, più o meno, con riferimento alla Biblioteca Vaticana: "Vieni e vedi" (a dir il vero, mi pare che nei fatti mi sia stato detto: "Vieni e lavora", ma lasciamo correre...). Vivere da dentro un'istituzione, da prefetto o con qualsiasi altro incarico, è un passo in avanti grandissimo per poterla conoscere: non solo per poterne perlustrare tutti gli angoli, quelli abitualmente accessibili o quelli più remoti, ma per respirarne l'aria, percepirne direttamente il clima, coglierne la missione proprio mentre la si sta vivendo. Si arriva cioè a conoscere una casa non come ospiti o visitatori ma come membri della famiglia (fra parentesi: una bella famiglia, quella della Biblioteca Apostolica, ricca di persone motivate, preparate, dedite e convinte della loro missione, e unite in una collaborazione impegnativa e feconda!, con le eccezioni, certo, che servono semplicemente a far meglio gustare il valore di ciò che è positivo).
Questa esperienza, per necessità di cose, è ancora più esclusiva della precedente, che riguardava i molti studiosi che frequentano la Biblioteca: un nutrito drappello di circa 150 persone al giorno, salvo i periodi di maggiore afflusso quando si superano le 200 unità, con una somma globale di più di 20.000 presenze all'anno. Penso che una parte o molti dei presenti ha (o avrà) esperienza di una biblioteca dall'interno e quindi si trovi (o si troverà) a comprendere dal vivo quanto sto dicendo.
Ma riconosco che, a questo punto, dobbiamo compiere un ulteriore passo e domandarci che cosa sia il cuore di questa conoscenza (la riflessione da cui ho preso spunto trovava buon gioco, qui, a presentare la mostra: "Vuoi conoscere? Vieni!"; ma a noi interessa quella conoscenza più profonda che permette di comprendere lo spirito di un'istituzione, la sua missione.
Cerco di precisare le due parole: istituzione dice non tanto una struttura senz'anima quanto piuttosto una realtà in cui si è sedimentata la storia delle persone che l'hanno sostenuta nei secoli, una realtà portatrice di qualcosa di grande per la quale vale la pena di impegnarsi fino in fondo. Questo qualcosa è appunto la missione dell'istituzione. E anche qui il termine è importante nella sua ricchezza di significati e di usi, per cui, dietro al senso tecnico di "scopo ultimo di un'istituzione" o "dichiarazione di intenti" che ne giustifica l'esistenza, ci troviamo a sentire tutta la pregnanza del termine missione usato in senso ecclesiale, come una altissima testimonianza di cui si diventa portatori.
2. La missione della Biblioteca Vaticana
La missione della Biblioteca Apostolica è stata descritta in vario modo e ho trovato molti riferimenti nei discorsi dei Papi che l'hanno visitata negli ultimi decenni (desidero ricercare e sintetizzare questi contenuti per l'intervento al convegno che si terrà sempre a novembre, 11-13). Fra l'altro, ci riferiamo al pensiero espresso dai Papi in visita, ma si sa che esso convoglia anche le riflessioni di altri: perché nulla parte dal nulla e perché vi sono spesso collaborazioni plurime a quegli interventi, accanto al "tocco" specifico di ogni Pontefice. Inoltre, per raggiungere lo stesso scopo, è utile ripercorrere la storia e vedere emergere da lì la risposta al nostro quesito sulla missione della Vaticana. Non è il momento di seguire nel dettaglio né l'una né l'altra pista, ma desidero raccogliere almeno alcuni elementi di sintesi, come ho avuto modo di fare più volte in occasione della riapertura (l'ho indicato alla conferenza stampa e l'ho visto ripreso: vuol dire che passano anche i messaggi "costruttivi"). Distinguo, nella missione della Biblioteca Vaticana, lo spirito di servizio, lo spirito umanistico e lo spirito universale.
2.1. Lo spirito di servizio
Lo spirito di servizio dice che la biblioteca è disponibile e aperta, con i suoi libri e con tutto il servizio richiesto, a chiunque desideri approfondire, studiare e ricercare.
Lo diceva già il Breve che papa Niccolò V Parentucelli nel 1451, agli inizi stessi della vita della Biblioteca, indirizzò a Enoch d'Ascoli: una biblioteca che sia communi doctorum virorum commodo (per l'utilità e l'interesse comune degli uomini di scienza): quindi una biblioteca che offra un clima di servizio e una tradizione di finezza, con un habitus ormai consolidato ma quotidianamente da motivare, concretizzato in tutte quelle "strumentazioni", adeguate e aggiornate, che siano necessarie agli studiosi per le loro ricerche.
2.2. Lo spirito umanistico
Lo spirito umanistico, che nel termine stesso si riallaccia all'epoca in cui ebbe origine la Vaticana, esprime il convinto sostegno alla ricerca compiuta in modo serio e documentato, con pazienza, con pacatezza – la pazienza e la pacatezza nel rifarsi adeguatamente alle fonti, nel verificare i dati, nel confrontare i testi, nel documentare le proprie affermazioni –, con capacità di confronto e con umiltà nell'espri¬mere le proprie conquiste. È, questo, un servizio umile ma preziosissimo alla verità, che non può essere mai compresa affrettata¬mente o attraverso slogan o con forzature, ma con un'indagine di cui l'Umanesimo ci è stato maestro indiscusso con la sua acribia filologica e con la sua ricerca attenta e accurata. Al tempo stesso lo spirito umanistico rammenta il punto di riferimento imprescindibile di ogni ricerca, che è l'uomo, la sua razionalità, la sua realtà spirituale, la sua dignità. Non certo per limitare le tematiche cui prestare attenzione, ma per rammentarne il punto di riferimento imprescindibile e per dare a ogni contenuto quello "spessore umano" che gli è necessario.
2.3. Lo spirito di universalità
Lo spirito di universalità, infine, tipico di ogni autentico sapere, è quello che fa della Biblioteca Vaticana – come si espresse papa Benedetto XVI nella visita del 25 giugno 2007 – «un'accogliente casa di scienza, di cultura e di umanità, che apre le porte a studiosi provenienti da ogni parte del mondo, senza distinzione di provenienza, religione e cultura». Questo spirito universale o, se si vuole, ecumenico si rinviene nella stessa biblioteca delle origini di papa Niccolò V: fu infatti papa Parentucelli a decidere di allestire una biblioteca universale, che coprisse le differenti discipline in cui si articola il sapere e che comprendesse il doppio versante linguistico latino e greco; lo stesso spirito fu per altro ulteriormente sviluppato nell'aggiunta del versante orientale, nell'ampliamento logicamente compiuto nei decenni successivi. E non si trattava semplicemente di archeologismo, ma di mettere davvero a confronto in modo positivo mondi diversi: infatti, oltre che dall'umanesimo, Niccolò V ha tratto l'idea della nuova biblioteca papale dalle necessità di un concilio ecumenico (universale appunto, a Ferrara e Firenze, 1438-1439), che per la prima volta tentò il confronto tra latini e greci nella loro cultura e loro modo differente di vivere la vita di fede e la vita della Chiesa. E si fa notare che la Vaticana è stata abitualmente segnata da momenti di confronto conciliare: - nata dopo il concilio di Firenze; - riformata dopo il concilio di Trento; - profondamente rinnovata dopo il Vaticano I; - di nuovo ripensata dopo il Vaticano II, dal quale ha assunto, in serena linearità col suo passato, appunto quello spirito di universalità che è sentito come apertura verso il mondo e insieme all'interno della vita della Chiesa. Nel concreto lo spirito universale ancor più si esprime, grazie al ruolo speciale assunto dalla Vaticana in quanto biblioteca dei papi e della Santa Sede in rapporto con le istituzioni religiose e civili, nell'opportunità di trovarsi in un crocevia di incontro fra persone e istituzioni di contesti lontani e disparati e di diventare così un luogo di collaborazioni e di intese culturali con istituzioni di ogni angolo del mondo. Si tratta di un servizio, di una situazione, di una missione che dice tutta l'universalità di ogni autentico sapere e l'amplissima possibilità di intesa e di collaborazione che ogni retta espressione culturale permette di realizzare. Una missione che la lungimiranza di Niccolò V ha affidato alla Biblioteca Apostolica Vaticana e che con riconoscenza i suoi attuali eredi – noi e un poco anche voi nel percorso di quest'anno – desideriamo con umiltà e convinzione continuare ad assolvere.